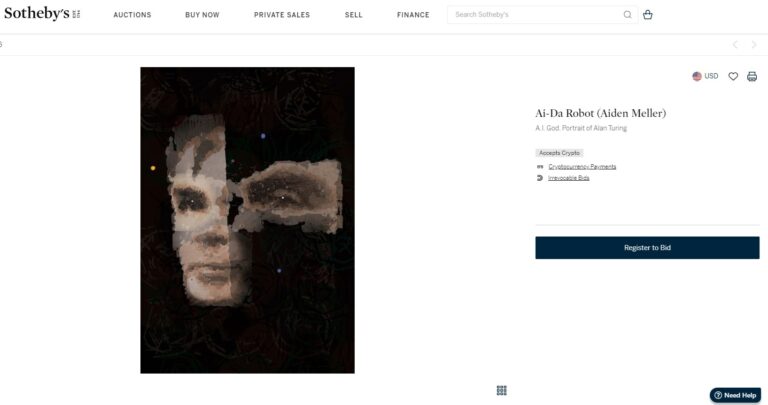di Gualtiero Marchesi
 [G]li specchi di Baj. “Certamente” scriveva nel lontano 1960 il poeta e critico d’arte francese André Pieyre de Mandiargues “si sarebbe già dovuto pensare a meglio utilizzare lo specchio tra gli innumerevoli materiali impiegati nell’arte moderna, tanto più che gli antichi specchi di Venezia avevano già mostrato, dietro le loro figurine incise, profondità pallide e insondabili. Spettava quindi a un italiano di constatarne e utilizzarne la scoperta. Le modificazioni apportate da Baj agli specchi sono principalmente di tre tipi: egli aggiunge alla loro superficie dei tratti di pittura e degli oggetti minuti, procedimenti che non sono molto differenti da quelli coi quali trattava poco fa i quadri accademici, figure o paesaggi, acquistati dal rigattiere, poiché lo specchio riflette il mondo esteriore allo stesso modo della pittura accademica, e in un caso come nell’altro lo spazio di quel mondo è sconvolto dalla brutale introduzione di un corpo estraneo. Infine Baj rompe lo specchio secondo linee concertate o lasciate al caso, e facendo questo egli costruisce una figura, sorta di scultura o d’architettura illuminata dalla materia smagliante, a mezza via tra due mondi eguali, tra lo spettatore e la sua immagine. Aggiungiamo che l’impiego dello specchio, secondo Baj, ‘risolve definitivamente il problema di far entrare lo spettatore all’interno dell’opera d’arte’. Resta da trovare solo il modo di impedirgli di uscirne, e allora l’inghiottimento dello stesso diverrà operazione metafisica. Anche per ciò, noi siamo pieni di fiducia nell’arte moderna!”. La citazione è congrua, credo, all’opera che ho scelto per questa puntata di Artfood. Si tratta di “Specchio”, del 1973, realizzata con una tecnica mista comprendente collage, specchi – appunto – e velluto. Il pubblico l’ha potuta ammirare di recente nella bella mostra “Enrico Baj. Gli anni del collage”, allestita alla Galleria civica di Cortina d’Ampezzo (catalogo Mazzotta). Di rado come in questo lavoro la sapienza compositiva dell’artista ha raggiunto un perfetto equilibrio, nell’accostamento delle tessere d’un mosaico multiforme e multidimensionale, giocate fra carte, stoffe, sminuzzati segmenti vetrosi. Il tutto a servizio d’un racconto al tempo stesso agile e possente, ludico e severo. L’incanto di un trastullo bicromatico – il bianco e il nero, e poi ancora il bianco, e ancora il nero – è affidato ad avvicendamenti della materia e dell’estro, che piega la materia stessa ad una finalità estetica ed emozionale. Con l’ammicco ironico e gaudioso di quei fiori, sbocciati nell’humus paradossale del supporto. La mia recensione di “Specchio” – tonificata dall’affetto e dalla profonda amicizia che mi legano, ormai da molti anni, ad Enrico Baj – fonda i suoi presupposti su una lettura rigorosamente filologica. Il bianco del piatto è la tavola, il letto di riso al nero di seppia la campitura. Corpi di seppie e calamaretti ricalcano le forme spezzate, suggerendo panorami forse terrestri – superfici antropizzate? tessuti a disegni geometrici? volti umani? – o forse siderali – galassie a convegno nell’universo? sinfonie di code di cometa? pianeti comunicanti in orbite contigue? -. E, tra il verdeggiare scherzosamente marzolino di cerfoglio e maggiorana, il liquido scuro arabesca il candore dei tondi, ne frange il riverbero nel tratteggio di profili orografici, a mo’ di mappaluna, o di identificazioni di arcane fisionomie. Amo quest’opera perché ne condivido il senso di una voluta semplicità. Come un desiderio – magari attraversato da un piccolo brivido angoscioso – di vuoto, che giunge dopo tanta pienezza. Per dirla con Italo Calvino, in un suo memorabile pezzo dedicato a Baj, vi si avverte la comune ripulsa per una realtà che altro non è se non “un cimitero di cianfrusaglie multicolori, un Mercato delle Pulci di dopo la fine del mondo, quando gli oggetti sparpagliati si risolleveranno in figure allucinate e prenderanno il posto degli esseri umani”.
[G]li specchi di Baj. “Certamente” scriveva nel lontano 1960 il poeta e critico d’arte francese André Pieyre de Mandiargues “si sarebbe già dovuto pensare a meglio utilizzare lo specchio tra gli innumerevoli materiali impiegati nell’arte moderna, tanto più che gli antichi specchi di Venezia avevano già mostrato, dietro le loro figurine incise, profondità pallide e insondabili. Spettava quindi a un italiano di constatarne e utilizzarne la scoperta. Le modificazioni apportate da Baj agli specchi sono principalmente di tre tipi: egli aggiunge alla loro superficie dei tratti di pittura e degli oggetti minuti, procedimenti che non sono molto differenti da quelli coi quali trattava poco fa i quadri accademici, figure o paesaggi, acquistati dal rigattiere, poiché lo specchio riflette il mondo esteriore allo stesso modo della pittura accademica, e in un caso come nell’altro lo spazio di quel mondo è sconvolto dalla brutale introduzione di un corpo estraneo. Infine Baj rompe lo specchio secondo linee concertate o lasciate al caso, e facendo questo egli costruisce una figura, sorta di scultura o d’architettura illuminata dalla materia smagliante, a mezza via tra due mondi eguali, tra lo spettatore e la sua immagine. Aggiungiamo che l’impiego dello specchio, secondo Baj, ‘risolve definitivamente il problema di far entrare lo spettatore all’interno dell’opera d’arte’. Resta da trovare solo il modo di impedirgli di uscirne, e allora l’inghiottimento dello stesso diverrà operazione metafisica. Anche per ciò, noi siamo pieni di fiducia nell’arte moderna!”. La citazione è congrua, credo, all’opera che ho scelto per questa puntata di Artfood. Si tratta di “Specchio”, del 1973, realizzata con una tecnica mista comprendente collage, specchi – appunto – e velluto. Il pubblico l’ha potuta ammirare di recente nella bella mostra “Enrico Baj. Gli anni del collage”, allestita alla Galleria civica di Cortina d’Ampezzo (catalogo Mazzotta). Di rado come in questo lavoro la sapienza compositiva dell’artista ha raggiunto un perfetto equilibrio, nell’accostamento delle tessere d’un mosaico multiforme e multidimensionale, giocate fra carte, stoffe, sminuzzati segmenti vetrosi. Il tutto a servizio d’un racconto al tempo stesso agile e possente, ludico e severo. L’incanto di un trastullo bicromatico – il bianco e il nero, e poi ancora il bianco, e ancora il nero – è affidato ad avvicendamenti della materia e dell’estro, che piega la materia stessa ad una finalità estetica ed emozionale. Con l’ammicco ironico e gaudioso di quei fiori, sbocciati nell’humus paradossale del supporto. La mia recensione di “Specchio” – tonificata dall’affetto e dalla profonda amicizia che mi legano, ormai da molti anni, ad Enrico Baj – fonda i suoi presupposti su una lettura rigorosamente filologica. Il bianco del piatto è la tavola, il letto di riso al nero di seppia la campitura. Corpi di seppie e calamaretti ricalcano le forme spezzate, suggerendo panorami forse terrestri – superfici antropizzate? tessuti a disegni geometrici? volti umani? – o forse siderali – galassie a convegno nell’universo? sinfonie di code di cometa? pianeti comunicanti in orbite contigue? -. E, tra il verdeggiare scherzosamente marzolino di cerfoglio e maggiorana, il liquido scuro arabesca il candore dei tondi, ne frange il riverbero nel tratteggio di profili orografici, a mo’ di mappaluna, o di identificazioni di arcane fisionomie. Amo quest’opera perché ne condivido il senso di una voluta semplicità. Come un desiderio – magari attraversato da un piccolo brivido angoscioso – di vuoto, che giunge dopo tanta pienezza. Per dirla con Italo Calvino, in un suo memorabile pezzo dedicato a Baj, vi si avverte la comune ripulsa per una realtà che altro non è se non “un cimitero di cianfrusaglie multicolori, un Mercato delle Pulci di dopo la fine del mondo, quando gli oggetti sparpagliati si risolleveranno in figure allucinate e prenderanno il posto degli esseri umani”.