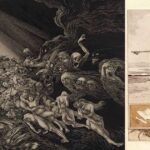L’idea dovette giungere dall’osservazione delle squame ossee dei coccodrilli. La resistenza della protezione era davvero assoluta e per vincere i possenti rettili era necessario colpirli nell’occhio o o alle giunture. I soldati romani si dotarono quindi – soprattutto alcuni reparti, di un’armatura non certo leggera, me performante per quanto riguardava la possibilità di movimento in sicurezza: la lorica squamata. Il nome “lorica” deriva da “lorum,” che in latino significa striscia di cuoio. Nell’età più antica era di cuoio, poi fu rinforzata con scaglie metalliche o di corno.
Con il tempo, pur non scomparendo del tutto il tipo più antico, divenne completamente metallica, in ferro, a maglie, a scaglie o a segmenti. L’unica lorica squamata romana completa, portata alla luce durante uno scavo del 2020 nella città antica di Satala, nel nord-est della Turchia, è stata ora ricostruita. Datata al V secolo d.C., l’armatura si trova in uno stato di conservazione straordinariamente buono. L’armatura ricomposta era dotata da una parte squamata – la scaglie metalliche, forate, erano uniti con fili e cucite su una tunica di pelle o di tessuto – e di una parte a maglia di ferro.
Qualcosa di simile, per la parte squamata – si parva licet componere magnis – alle paillettes delle borsette da sera, che si usavano tempo fa. La lorica squamata ora recuperata era stata evidentemente gettata in un angolo e lì è rimasta per per 1600 anni circa, perdendo il supporto organico di stoffa o di cuoio, ma mantenendo vicine le strutture metalliche che componevano la corazza.
Gli scavi archeologici hanno restituito centinaia di scaglie di varie forme e dimensioni in tutto l’impero, appartenute a questo tipo di corazza. Ad esempio, Von Groller nel 1912 ne classificò 36 solo tra quelle rinvenute a Carnuntum. Le scaglie, di norma costituite da piastrine metalliche romboidali con bordi arrotondati, erano di ferro o bronzo, lunghe dai due ai tre centimetri e dotate di piccoli fori per permetterne l’assemblaggio. Talvolta stagnate, le scaglie erano affiancate e unite a coppie da un corto spezzone di filo di bronzo; l’intera fila così ottenuta veniva poi cucita su un supporto di tessuto, sempre utilizzando i fori predisposti sulla superficie. Variando la lunghezza delle file di scaglie, era possibile costruire corazze di qualsiasi misura: un sistema semplice che consentiva la facile sostituzione dei pezzi danneggiati o mancanti.
Le corazze a scaglie erano generalmente indossate da figure di alto rango, come centurioni o portainsegne (aquilifer, signifer, imaginifer), oppure da cavalieri. Ed è forse ai cavalieri che la lorica restaurata poteva essere destinata. I punti meno sensibili al colpo dei nemici erano di maglia di ferro, che consentiva l’indispensabile mobilità del cavaliere.

E ora osserviamo bene la struttura. A livello del ventre, i costruttori della lorica dismisero le squame e inserirono una sezione a maglia ferrata. E ciò per consentire al legionario – probabilmente un cavaliere – di piegarsi in avanti, funzione fondamentale per procedere in velocità e torcersi per colpire.
Le analisi con raggi X e micro-TC hanno mostrato che l’armatura era quasi intatta. Nel 2021, i conservatori del Laboratorio regionale di restauro e conservazione di Erzurum hanno iniziato il meticoloso lavoro di riassemblaggio dei pezzi nella loro configurazione originale. Questo lavoro ha incluso tre sezioni di cotta di maglia e le scaglie sovrapposte della lorica squamata, che arrivano fino alla vita e possono aver contribuito a risolvere alcuni dei problemi dell’armatura a scaglie, come la pesantezza e la limitata flessibilità. La cotta di maglia (lorica hamata) era più costosa da produrre e richiedeva riparazioni specialistiche, a differenza della squamata, che poteva essere riparata facilmente dai legionari stessi. La presenza di elementi di cotta di maglia in questa armatura suggerisce che potrebbe essere appartenuta a un ufficiale.