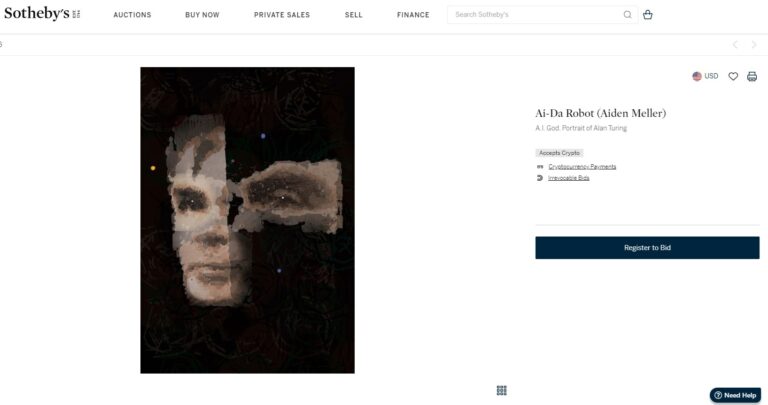PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

di Sara Fontana ed Enrico Giustacchini
Stile Arte ha intervistato Daniel Buren, uno dei protagonisti dell’arte contemporanea mondiale. Da oltre quarant’anni lei ricorre nella sua attività artistica – invariabilmente – allo stesso elemento: un elemento che ha definito “utensile visivo”. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Si tratta di un segno visivo semplice ma distintivo: un motivo a bande verticali di 8,7 centimetri di larghezza, dove il bianco si alterna ad altri colori. In effetti è sempre lo stesso, assolutamente immutabile da quarantatré anni. La sola cosa che non cambia è la misura delle righe, mentre tutto il resto, dalle idee ai materiali utilizzati, cambia costantemente, in funzione dell’obiettivo, dei tempi e del luogo. L’ho chiamato “utensile visivo” perché è come un martello, un metro o qualsiasi altro attrezzo. Se il metro è un attrezzo che serve a misurare, questo è un attrezzo visuale che permette di vedere, di misurare e di fare molte altre cose. Nel corso del tempo, poi, è divenuto anche una firma che consente di riconoscere il mio lavoro e, paradossalmente, mi evita di firmarlo. C’è una ragione particolare nella scelta della riga e della sua dimensione? Le righe sono l’esito di un processo naturale iniziato verso il 1964, quando dipingevo opere astratte caratterizzate da larghe strisce verticali. Nell’autunno del 1965, su un mercatino di Parigi, trovai per caso del cotone a righe, quello usato per fare cuscini e materassi, simile ai tendoni delle terrazze di caffè e ristoranti. Fui immediatamente attratto da quel materiale, forse perché somigliava ai quadri che stavo realizzando da oltre un anno. E, dato che quelle righe erano migliori delle mie, comprai molti metri di tessuto – la larghezza delle righe era appunto di 8,7 centimetri – e cominciai a lavorarci. Attenzione, però, a non confondere il tessuto con il ready-made, perché, almeno fino al 1967, sul tessuto c’era sempre la pittura. Dal 1967 ho fatto arretrare la pittura, ed è subentrato un utilizzo più concettuale e più astratto della sequenza bianco-colore-bianco-colore. Fu solo allora che pensai per la prima volta alla relazione delle mie opere con l’architettura e con lo spazio. E’ stata per me una riflessione cruciale, una scelta che non ho più abbandonato. Le righe – come ho detto – sono divenute un modello, uno strumento estetico che si piega a migliaia di possibilità.
Lei lavora sempre “in situ”. Quali sono le motivazioni di questo orientamento? Quanto è importante la possibilità di interagire con le strutture, le architetture esistenti? La scelta di lavorare in situ è parte integrante di quella riflessione. Significa realizzare un’opera in un luogo e in modo specifico per quel luogo. Il primo passo – il più difficile – è misurarsi con le caratteristiche del luogo, tenendo conto della sua storia e cercando di cogliere la natura, il rapporto con l’architettura e anche con le persone che ci vivono. E’ indispensabile tentare d’immaginare i modi in cui un lavoro potrebbe interagire o essere fruito, a partire proprio dal punto in cui viene collocato. Un’opera perturba l’ambiente in cui è ubicata: oltre alle “dinamiche di reazione” che essa potrebbe innescare, contano le “dinamiche di relazione” e i “mutamenti nella percezione”. A maggior ragione in un luogo familiare. Il fatto che l’intervento artistico in situ sia “attaccato” al luogo, porta inevitabilmente a riflettere su questioni fondamentali che riguardano l’opera d’arte. Innanzitutto, un lavoro in situ non consente speculazioni, poiché non può essere manipolato né trasportato altrove. E quanto è importante la collaborazione con le persone che in quel luogo vivono ed operano? Lavorare in situ vuol dire lavorare con il luogo, con la sua storia, ma soprattutto con la gente. Anche se al termine dell’impresa ciò che è immediatamente visibile è il luogo, è indispensabile stabilire un dialogo con la comunità, pur invisibile, rispettandone il senso di appartenenza. Ogni situazione è diversa, ma in molte occasioni ho potuto constatare quanto la gente fosse più importante di tutti gli altri elementi in gioco. Qual è il ruolo del colore nel suo lavoro? Lei ha parlato, in proposito, di scelte oggettive, al di fuori del proprio gusto personale, fatte per stabilire una relazione immediata con l’osservatore. Vuole spiegarci meglio questo concetto? Il colore ha effettivamente un ruolo importante nel mio lavoro, non però come un elemento del gusto o della sensibilità ma come un elemento astratto. Quando sostengo in proposito una posizione “oggettiva”, intendo dire che utilizzo il colore in funzione del mio gusto, che è praticamente indifferente di fronte ai vari colori (per me un rosso equivale a un blu, a un verde, a un nero). So bene che la gente reagisce a determinati colori in modi differenti, ma credo pure che sia quasi impossibile conoscerne la reale percezione. E’ evidente che anch’io ho un gusto per il colore, come tutti, ma deliberatamente non lo seguo e talvolta faccio scegliere ad altri i colori dei miei interventi, con il rischio che la scelta cada su colori che non mi piacciono. Ma questo non significa nulla, poiché ciò che m’interessa è un’idea del colore, non il colore simbolico di stati d’animo o di luoghi. E cerco di usare il colore in modo che esso sia, anche per chi guarda, il più oggettivo possibile. Se so che in un luogo un colore ha un particolare significato simbolico – ad esempio, il bianco ed il viola in Giappone sono associati all’idea di morte -, generalmente lo evito. Le sue installazioni portano inevitabilmente ad un’attenzione del pubblico anche verso il contesto, architettonico o ambientale, in cui sono inserite. Ciò può portare a considerazioni di ordine storico, filosofico, politico sul ruolo di tali luoghi o, ad esempio, sulle condizioni in cui si trovano, sui loro destini futuri. Si sente coinvolto in prima persona in questo processo? O ritiene che il ruolo dell’artista si esaurisca nel suggerire immagini, forme, sensazioni, che devono poi essere elaborate autonomamente da altri? In tutti i progetti che ho potuto realizzare, sia quelli all’interno dei centri storici sia quelli in aree dismesse o periferiche, il mio lavoro non è stato semplicemente quello di posizionare un oggetto, ma di interrogarmi su quel luogo particolare e di riproporre la domanda a visitatori e passanti. Applicando il mio “utensile visivo” a muri, colonne, cartelloni per affissioni, bandiere, eccetera, ho cercato di rimettere in discussione il rapporto tra l’unicità dell’opera d’arte e il suo contesto, riportando l’attenzione dell’osservatore su un luogo specifico, e quindi sulle sue condizioni sociali ed economiche. Il mio “studio” si trova di volta in volta dove sto lavorando, quindi ho avuto e ho tuttora infiniti studi, tutti aperti e pubblici. E’ stato detto, a proposito delle sue opere, che esse vorrebbero dimostrare che “non è l’artista, bensì la cornice generale, a dare il carattere di artisticità al gesto artistico”. E’ d’accordo con questa definizione? Penso che sia il contesto che crea tutti i lavori, non soltanto il mio. Solo che la maggior parte delle opere ha la pretesa di essere autonoma, il che è falso. Che io sappia, non esistono lavori autonomi, tutti dipendono dal contesto, oggi come in passato. Fuori dal contesto non troviamo nulla, eccetto l’illusione che la produzione artistica sarebbe autonoma. Cosa appunto non vera, a mio parere. Sono riflessioni che però chiamano in causa una serie di considerazioni critiche sull’arte, per esempio che l’arte appartenga alla fine a chi la può acquistare…
LE QUOTAZIONI E I RISULTATI D’ASTA SEMPRE AGGIORNATI DELLE OPERE DI DANIEL BUREN www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?action=search&searchtype=p&searchFrom=auctionresults&entry=daniel%20buren Per ulteriori approfondimenti: www.stilearte.it ã America Oggi e Stile didascalia Daniel Buren

Daniel Buren – Quotazioni gratis, intervista, poetica, immagini e video
"Le righe sono l’esito di un processo naturale iniziato verso il 1964, quando dipingevo opere astratte caratterizzate da larghe strisce verticali. Nell’autunno del 1965, su un mercatino di Parigi, trovai per caso del cotone a righe, quello usato per fare cuscini e materassi, simile ai tendoni delle terrazze di caffè e ristoranti. Fui immediatamente attratto da quel materiale, forse perché somigliava ai quadri che stavo realizzando da oltre un anno"